
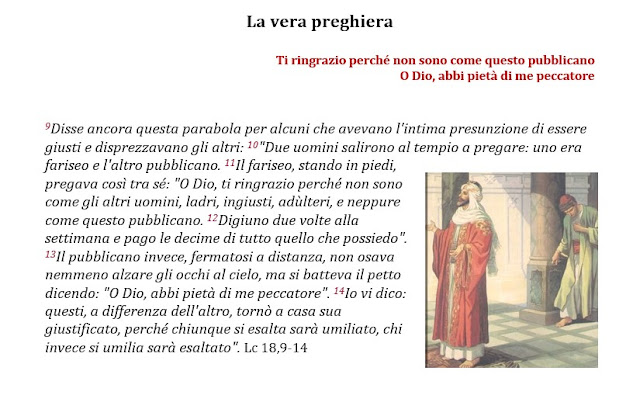
Come
la parabola della povera vedova di domenica scorsa, anche questa parabola del
fariseo e dell'esattore delle tasse è un prezioso insegnamento sulla preghiera.
Questa terza parabola, parlando di due uomini che salgono al tempio per
pregare, più che sull’insistenza e la necessità della preghiera, vuole insegnare
il giusto atteggiamento.
Mentre, infatti, con la parabola della vedova, Gesù
insegna la necessità di pregare sempre, senza stancarsi o, se si vuole, senza
incattivirsi, con questa intende correggere chi si considera giusto e,
addirittura, disprezza gli altri che non sono come lui. Gesù narra questa
parabola, cioè, per insegnare che non è questo il modo di avvicinarsi a
Dio.
Alcune persone sono sicure e orgogliose della propria rettitudine
e non si siederebbero mai alla tavola dei peccatori dove, invece, si sedeva
Gesù (cfr. Lc 5,30). "Si considerano giusti e disprezzano gli altri",
anche se solo Dio conosce i cuori di tutti. Ebbene, Gesù vuole insegnarci che
questo non può essere l'atteggiamento di chi pretende pregare. La parabola,
infatti, non ha altro scopo se non quello di sottolineare che l'incontro col
Signore non può mai partire da presunti diritti acquisiti.
Gesù non sta valutando la condotta del fariseo, da una
parte, e dell'esattore delle tasse, dall'altra, ma il loro modo di pregare. La
confessione del Fariseo ("Non sono come gli altri uomini: ladri,
ingiusti, adulteri; e non sono come questo esattore delle tasse. Digiuno due
volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che ho") corrisponde
a verità. Così come è vero che il comportamento del pubblicano, è da
sfruttatore del suo popolo a servizio dell’impero oppressore, ma, nel momento
della sua preghiera, è lui il vero orante che, riconoscendolo, si mette
umilmente nelle mani di Dio.
La fragilità della preghiera del fariseo sta proprio
nella sua certezza di essere irreprensibile agli occhi di Dio e degli altri.
Sentendosi sicuro e senza colpe, non ha nulla da chiedere. Soddisfatto delle
sue osservanze, pensa di non avere bisogno d’altro. Ringrazia Dio di non essere
come gli altri e, compiaciuto, espone la sua più che lodevole condotta: "Digiuno
due volte alla settimana", continua a ripetere, "e pago la decima di tutto
ciò che ho".
La forza della preghiera del pubblicano scaturisce
proprio dal riconoscimento della sua indegnità. Restando in disparte, non osava
nemmeno alzare gli occhi, ma si batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi
pietà di questo peccatore". Non ha altro che i suoi grandi peccati,
ma, allo stesso tempo, è giusto perché chiede misericordia. È l'unica preghiera
che può fare e, poiché è sincera, è la sua preghiera che Dio ascolta.
La giustizia che il fariseo si riconosce è un dono che
solo Dio può concedergli, ma se non lo chiede, a differenza del disprezzato
pubblicano, non lo avrà. "Io vi dico che questo
[pubblicano]”, conclude, infatti, Gesù, “è andato a casa sua giustificato, e
quello no". Perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà
esaltato”.
Questa frase finale, che compare anche in Lc 14,11 (chi
si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato), evidenzia l'invito
all'umiltà come condizione assoluta della vera preghiera, espressa nel Kyrie
eleison (Signore, abbi pietà), con cui inizia ogni Eucaristia.
È la vera "preghiera del cuore", capace di
trasformare l'esistenza di chi - come il Pellegrino russo - non cessa di
ripeterla, rivolgendo a Cristo la petizione che il pubblicano della parabola
elevava a Dio nel Tempio: "Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me
peccatore". Migliaia e migliaia di volte al giorno, il pellegrino
ripete queste parole, finché non è più lui a esprimere questa preghiera, ma è
la preghiera a esprimere lui.
